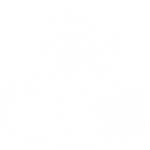Sessantacinque anni separano la Salita al Calvario di Pieter Bruegel il Vecchio dalla Cena in Emmaus di Rembrandt. Del 1564 il primo, del 1629 il secondo. Diversa la geometria della rappresentazione, diversi il dinamismo cromatico e la strategia della luce. Perché abbiamo voluto accostare opere così distanti? In modi certamente assai diversi, Bruegel e Rembrandt portano dentro la spirale della modernità il racconto della Croce e della Resurrezione di Gesù, e ne custodiscono il paradosso e lo scandalo, ne conservano memoria, facendone risaltare la fibra essenziale. Una forte carica interrogativa, che tocca e scuote i fondamenti dell’esperienza cristiana, avvicina le due opere. Giungerà al suo Golgota il Cristo smarrito della Salita al Calvario? Quale strada può percorrere per vincere l’indifferenza da cui è circondato? Questa è la domanda che troviamo in Bruegel. Ed è radicale, perché si porta appresso il fardello pesante di un dubbio sull’efficacia del simbolo cristiano. Per sostenere il peso di questa carica interrogativa è stato necessario percorrere l’intrico di strade che porta al Golgota, nella modernità e oltre. Alcune strade, non tutte, ovviamente. Lo abbiamo fatto seguendo le tracce, ormai poco visibili, di un «Dio che muore», lungo tutto il suo drammatico tragitto, dalla «salita» al «sepolcro», raccogliendo, lungo la strada, le parole, le grida, i gesti che lo accompagnano. Non ci siamo fermati a Bruegel. Abbiamo cercato i segni di altre croci: in Bosch, in Grünewald e Holbein, in Goya, in Velàzquez, in Ensor, in Rouault, fin dentro il Novecento, dove il legno storto della croce fronteggia il nulla e talvolta ne è risucchiato. Alcune di queste croci, quella di Matthias Grünewald ad esempio, che sovrasta l’altare di Isenheim, a Colmar, o il Cristo deposto nel sepolcro di Hans Holbein sono spine nel fianco del pensiero filosofico e teologico d’Occidente. Ancora attraggono pensiero, accompagnando la storia d’Occidente. Fanno da specchio al dolore dell’uomo, e ne cercano il senso.
Se poi guardiamo alla Cena in Emmaus di Rembrandt, a quel buio sfibrato che avvolge anche il Cristo, e a quella luce che emerge dall’ombra come un enigma, l’evento della resurrezione, narrato parcamente nei Vangeli, ma rivestito di significati immaginifici e consolatori nella storia della cristianità, sembra spalancare una interrogazione nuova: che cosa può ancora credere il “credente”? Che significato può avere il racconto della resurrezione in tempi, come i nostri, di radicale scetticismo e di dubbiosa ricerca? Quale narrazione di quell’evento può aiutarci a darne una lettura che non strida con l’esigenza contemporanea di uscire dal linguaggio del mito? In pochi tratti, quasi in bilico fra l’ombra e la luce, Rembrandt ci fa guardare alla resurrezione come a un possibile: non a una mitica cancellazione della morte, ma a qualcosa che resta, una piccola brace di vita che arde anche nella notte. Quel Cristo che sprofonda dal buio nella luce, lasciando sul tavolo il pane e la parola condivisi, quel Cristo, può essere ancora fonte di vita e di senso. La sua sparizione, l’assenza di ogni Dio sulla Terra, sono forse i segni con cui ci dobbiamo confrontare per decifrare i racconti evangelici. Forse è in questo vuoto di ogni Dio, nelle tenebre rischiarate appena da qualche bagliore, che possiamo metterci in cerca del senso ultimo della «buona notizia»: il pane e la parola da condividere, la giustizia da perseguire, la benevolenza in cui avvolgere il mondo. Pur nella loro radicale diversità, la Salita al Calvario e la Cena in Emmaus ritraggono qualcosa che si ritira: la croce in Bruegel, la figura del Risorto in Rembrandt. Ma nel loro venir meno non perdono la loro forza, ne acquistano una nuova.